 Il primo astronauta italiano era sull’Apollo 11
Il primo astronauta italiano era sull’Apollo 11
Gli astronauti italiani ufficialmente sono 7, ma in realtà ce n’è uno molto più illustre di loro, uno dei tre che nel 1969 presero parte al primo sbarco umano sulla luna. E’ Michael Collins (al centro nella foto, a sinistra Neil Armstrong, a destra Buzz Aldrin).
Prima ancora di Maurizio Cheli, Samantha Cristoforetti, Umberto Guidoni, Franco Malerba, Paolo Nespoli e Luca Parmitano. Cheli (modenese del 1959) nel 1996 portò nello spazio il satellite italiano Tethered Satellite; Cristoforetti (milanese del 1977) è stata selezionata nel 2009 dall’Agenzia Spaziale Europea come astronauta; Guidoni (romano del 1954) nel 1994 vola per la prima volta nello spazio sulla Columbia, poi una seconda volta nel 2001 sull’Endeavour che porta lui, primo europeo, sulla stazione orbitale internazionale; Malerba (genovese del 1946) è stato il primo italiano ad andare nello spazio nel 1992 sullo Space Shuttle Atlantis; Nespoli (milanese del 1957) nel 2007 è stato a bordo dello Space Shuttle Discovery passeggiando nello spazio e nel 2010 è tornato con la Sojuz TMA-20 sulla stazione spaziale internazionale; Parmitano (catanese del 1976) nel 2013 salirà a bordo della stazione spaziale internazionale per 8 mesi (da maggio a novembre); Vittori (viterbese del 1964) nel 2002 è salito a bordo della stazione spaziale internazionale e nel 2005 ha pilotato la Sojuz TMA-6 nella manovra di attracco alla stazione orbitante ed è il primo europeo divenuto comandante di Sojuz, inoltre nel 2011 ha svolto un’altra missione sullo Space Shuttle STS-134.
 Ed eccoci al primo italiano nello spazio: Michael Collins, nato il 31 ottobre 1930 a Roma nell’attico al quinto piano di via Tevere 16. In pieno fascismo il generale di divisione James Lawton Collins, conclusa la sua missione diplomatica a Saigon, fu inviato all’ambasciata americana di Roma come addetto militare ed è nella capitale italiana che sua moglie, l’irlandese Virginia Steward, diede alla luce Michael. Quando fu il momento di decidere se intraprendere la carriera diplomatica (come avrebbe voluto mamma) o quella militare (come avrebbe preferito papà), Michael scelse a 18 anni l’Accademia militare di West Point entrando poi nell’Air Force e da lì alla base sperimentale di Edwards come collaudatore di aerei a reazione. Nell’ottobre 1963 è stato uno del terzo gruppo di primi astronauti nominati dalla NASA e dopo essere stato pilota di riserva nella missione Gemini 7, con la missione Gemini 10 andò per la prima volta in orbita, camminando nello spazio per un’ora fuori dal modulo. Ma il suo momento di gloria lo ebbe quando il 18 luglio 1969 lasciò Cape Kennedy alla guida del missile che portava con sé il Lem (Lunar Excursion Module), il primo modulo lunare.
Ed eccoci al primo italiano nello spazio: Michael Collins, nato il 31 ottobre 1930 a Roma nell’attico al quinto piano di via Tevere 16. In pieno fascismo il generale di divisione James Lawton Collins, conclusa la sua missione diplomatica a Saigon, fu inviato all’ambasciata americana di Roma come addetto militare ed è nella capitale italiana che sua moglie, l’irlandese Virginia Steward, diede alla luce Michael. Quando fu il momento di decidere se intraprendere la carriera diplomatica (come avrebbe voluto mamma) o quella militare (come avrebbe preferito papà), Michael scelse a 18 anni l’Accademia militare di West Point entrando poi nell’Air Force e da lì alla base sperimentale di Edwards come collaudatore di aerei a reazione. Nell’ottobre 1963 è stato uno del terzo gruppo di primi astronauti nominati dalla NASA e dopo essere stato pilota di riserva nella missione Gemini 7, con la missione Gemini 10 andò per la prima volta in orbita, camminando nello spazio per un’ora fuori dal modulo. Ma il suo momento di gloria lo ebbe quando il 18 luglio 1969 lasciò Cape Kennedy alla guida del missile che portava con sé il Lem (Lunar Excursion Module), il primo modulo lunare.  Nei tre giorni di missione, Collins lasciò sulla luna i compagni di viaggio Buzz Aldrin e Neil Armstrong, che poi col Lem tornarono al modulo base in orbita attorno alla luna. Sul nostro satellite i primi uomini lasciarono la bandiera americana, le loro scarpe, apparecchiature scientifiche e una placca (nella foto) con indicata la frase: Qui uomini del pianeta Terra fecero il primo passo sulla Luna, Luglio 1969 d.C. Siamo venuti in pace per tutta l’umanità.
Nei tre giorni di missione, Collins lasciò sulla luna i compagni di viaggio Buzz Aldrin e Neil Armstrong, che poi col Lem tornarono al modulo base in orbita attorno alla luna. Sul nostro satellite i primi uomini lasciarono la bandiera americana, le loro scarpe, apparecchiature scientifiche e una placca (nella foto) con indicata la frase: Qui uomini del pianeta Terra fecero il primo passo sulla Luna, Luglio 1969 d.C. Siamo venuti in pace per tutta l’umanità.

Esistono gli alieni? Risponde Margherita Hack
Ospite del Comune di Padova per le celebrazioni dei 400 anni dalle scoperte galileiane, l’astrofisica fiorentina Margherita Hack il 6 maggio ha tenuto una conferenza al Palazzo della Ragione; e tra i tanti giovani venuti ad ascoltarla, oltre a un folto numero di studenti dell’Abruzzo invitati per l’occasione, c’era anche Aaron Ciechanover, l’israeliano premio Nobel 2004 per la Chimica.
Che esistano nell’universo altri esseri viventi è non solo molto probabile, ma sarebbe strano se fossimo gli unici. Per idee del genere Giordano Bruno fu messo al rogo, ma oggi si può dire che è assurdo pensare che tra i 400 miliardi di sistemi solari presenti nella nostra sola galassia (e di galassie ce ne sono miliardi) sia abitato solo il nostro pianeta.
Margherita Hack ha spiegato come si stanno scoprendo pianeti extrasolari lontanissimi anni luce da noi. Intanto va detto che tutti i pianeti orbitano, come la Terra, attorno al loro sole in senso antiorario; e che la distanza tra una stella (sole) e l’altra è 100 milioni di volte più grande del diametro medio di una stella. Nel 1995 si è scoperto il primo pianeta extrasolare che dista da noi 40 anni luce. Ha però caratteristiche molto diverse dalla Terra: grande come Giove, presenta un anno di soli 4 giorni e mezzo, inoltre è gassoso, caldissimo e molto vicino al suo sole. Ed è strano notare che in altri sistemi solari le caratteristiche del nostro sono ribaltate: da noi infatti i pianeti grandi sono gassosi e al margine del sistema…
Oggi di pianeti extrasolari ne conosciamo più di 300 e per scoprirli non possiamo usare la vista perché essi appaiono annegati dietro la luce stellare, quindi non li vediamo. Li scopriamo invece per le minime oscillazioni che l’avvicinarsi al loro sole provocano alla stella di riferimento. Questo è possibile per pianeti di grandi dimensioni; una cinquantina di piccoli li abbiamo invece intuiti col metodo del transito, ossia per via dell’ombra provocata dal loro passaggio davanti al loro sole. Il terzo sistema è quello della relatività generale di Einstein. Se osserviamo una galassia lontana, la galassia più vicina funge da lente di ingrandimento che devia i raggi luminosi provenienti da quella lontana. Così la luce più distante viene amplificata con un effetto che dura tra i 10 e i 20 giorni; pure un pianeta funge da lente, ma per meno tempo. Su un milione di stelle osservate, questo metodo ha permesso di scoprire solo 6 o 7 pianeti. 
Al momento conosciamo solo due tipi di pianeti extrasolari simili alla Terra, con presenze di silicati, grafite ecc. Il più simile al nostro è lontano 20 anni luce. Mentre il Sole dista da noi solo 8 minuti/luce, nella nostra sola galassia esistono stelle distanti da noi anche 100.000 anni luce! Sarà possibile osservare altri pianeti col telescopio europeo del diametro di 40 o 50 metri che sarà costruito a terra sotto la direzione dell’astrofisico italiano Roberto Gelmozzi.
Se la vita certamente alberga sotto altre stelle, nel nostro sistema solare può esistere? Alla domanda Margherita Hack ha risposto che Venere, se avesse l’atmosfera come la nostra potrebbe avere una temperatura di 40°, ma le sonde sovietiche anni fa trovarono che al suolo il calore raggiunge i 500 gradi per via di un forte effetto serra. Su Marte le temperature sono più accettabili con 20 gradi di giorno e -80 la notte (come nei più freddi inverni siberiani), ma a renderlo più inospitale è la tenue atmosfera ricca di anidride carbonica. Tuttavia su Marte potrebbero esserci stati o esserci tuttora dei batteri, dato che ci sono tracce d’acqua, di fiumi e di ghiacci. Sul pianeta rosso potrebbe esserci qualche forma di vita sotterranea che sopravvive in situazioni estreme, come in Antartide vivono batteri a -100° o nell’oceano ne sguazzano altri nonostante la pressione di 100 atmosfere. Sarebbe interessante studiarne il Dna per vedere se è simile al nostro. Può anche essere che altrove la vita si sviluppi con un sistema diverso e quindi non basato sul carbonio. 
Degli altri pianeti sappiamo poco, ma sono gassosi. Forse sui satelliti di Giove potrebbero esserci forme elementari di vita in oceani sotterranei. Titanio, il grande satellite di Saturno, presenta laghi e fiumi: non di acqua, ma forse di metano a 200 gradi sottozero.
Ecco allora che per sapere se ci sono altre forme di vita intelligente nell’universo, esiste da anni il progetto SETI che capta segnali radio umani puntando le antenne verso le remote lande del cosmo: ma dal 1964 non si è captato nulla di valido.
Ipotizzando di essere raggiunti da altre civiltà, l’astrofisica ricorda che più ci si avvicina alla velocità della luce e più i corpi ingrandiscono, quindi a tutt’oggi è difficile ipotizzare sistemi di locomozione adatti; inoltre se una civiltà intelligente guardasse la Terra, si accorgerebbe subito che da noi c’è vita e tenterebbe di comunicare. Ma nella scienza, come ha dimostrato Galileo, tutto è possibile: 30 anni fa uno scienziato svizzero fu preso per pazzo quando disse che la velocità di alcune galassie era alta: Eppure la sua teoria oggi è da poco accettata e serve a misurare non ciò che si vede, ma ciò che si muove, ossia la materia oscura che costituisce la gran parte dell’universo.
 Fotografato il Punto G
Fotografato il Punto G
Aristotele lo chiamava il punto della beatitudine. A un ricercatore italiano si deve la prima “fotografia” del fantomatico Punto G, ovvero del punto del piacere femminile. E’ il sessuologo Emanuele Jannini, docente di Sessuologia Medica all’Università de L’Aquila, il quale ha sottoposto ad ecografia due gruppi di giovani donne: il primo campione dichiarava di non avere orgasmi vaginali, il secondo sì. Cercando in un punto dove solitamente l’ecografia non guarda, cioè in corrispondenza dell’osso pubico, il professore ha constatato che le donne che affermavano di avere orgasmi interni possedevano un ispessimento della parete in corrispondenza del clitoride; le altre no. Di qui la considerazione che quello è il Punto G, (detto così dal cognome del ginecologo tedesco Ernst Grafenberg che negli anni ’50 parlava di una zona ricca di terminazioni nervose, che nella parte anteriore della vagina sotto l’uretra, la stimolazione fa ingrossare). Nella prima puntata de La Gaia Scienza su la 7, il 26 aprile 2009 il sessuologo ha affermato che sono più le donne sprovviste del Punto G di quelle che ce l’hanno; e che comunque averlo o non averlo non cambia nulla nei rapporti sessuali. Certo, dal punto di vista del piacere è più fortunata chi ce l’ha.
Come spiega il professor Andrea Lenzi dell’Università de L’Aquila, se la stimolazione di questo punto diventa intensa, esso si gonfia producendo contrazioni dell’utero, portando all’orgasmo e attivando la produzione di un liquido chiaro che nella composizione chimica è simile a quello della prostata: tanto che alcuni ritengono che il Punto G altro non sia che un abbozzo di prostata non sviluppata.
 Almeno 10 civiltà evolute nella Via Lattea
Almeno 10 civiltà evolute nella Via Lattea
Ci sono da 10 a 5.000 pianeti, nella nostra galassia, che potrebbero essere abitati da civiltà evolute. Questo secondo due interpretazioni dell’equazione di Drake, espressa nel 1961 dal radioastronomo americano Frank Drake, presidente del SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) e tuttora accettata dalla comunità scientifica. Questa formulaindica che il numero di civiltà possibili nella sola Via Lattea è pari al numero di anni di vita media di una civiltà. Ma è una mera ipotesi basata su dati solo molto parzialmente verificabili.  Quel che è più assodato invece, è che il nostro Sole è solo una delle almeno 400.000 trilioni di stelle esistenti nell’universo e che la Via Lattea (la nostra galassia in cui sono presenti 400 miliardi di stelle del tipo della nostra) è una dei 200 miliardi di galassie esistenti (miliardo più, miliardo meno). Quindi, come sostiene anche Piergiorgio Odifreddi (logico matematico), per il calcolo delle probabilità è più facile ritenere che la vita si sia sviluppata anche altrove, piuttosto che conservare la retrograda convinzione che la Terra sia l’unica depositaria di questa qualità. D’altra parte perfino la Chiesa cattolica (storicamente un passo indietro rispetto alla scienza) oggi accetta la possibilità che altri esseri umani vivano altrove nell’universo. Non resta che da chiedersi, come fece Enrico Fermi nel 1950 davanti ad un piatto vuoto: Dove sono tutti quanti? Perché non si fanno vedere? Dal 1963 il radiotelescopio di Arecibo a Puerto Rico, ha iniziato ad ascoltare i segnali radio provenienti dagli spazi siderali. E nel 1974 da lì fu inviato nello spazio un messaggio radio terrestre in codice, formato da 1.679 bit ideati dallo stesso Drake docente alla Cornell University, all’“indirizzo” della Costellazione di Ercole (M13 in gergo scientifico) scoperta nel 1715 dall’astronomo inglese Edmond Halley. Se la “letterina” qui riportata in foto, venisse captata da radiotelescopi alieni, racconterebbe chi siamo.
Quel che è più assodato invece, è che il nostro Sole è solo una delle almeno 400.000 trilioni di stelle esistenti nell’universo e che la Via Lattea (la nostra galassia in cui sono presenti 400 miliardi di stelle del tipo della nostra) è una dei 200 miliardi di galassie esistenti (miliardo più, miliardo meno). Quindi, come sostiene anche Piergiorgio Odifreddi (logico matematico), per il calcolo delle probabilità è più facile ritenere che la vita si sia sviluppata anche altrove, piuttosto che conservare la retrograda convinzione che la Terra sia l’unica depositaria di questa qualità. D’altra parte perfino la Chiesa cattolica (storicamente un passo indietro rispetto alla scienza) oggi accetta la possibilità che altri esseri umani vivano altrove nell’universo. Non resta che da chiedersi, come fece Enrico Fermi nel 1950 davanti ad un piatto vuoto: Dove sono tutti quanti? Perché non si fanno vedere? Dal 1963 il radiotelescopio di Arecibo a Puerto Rico, ha iniziato ad ascoltare i segnali radio provenienti dagli spazi siderali. E nel 1974 da lì fu inviato nello spazio un messaggio radio terrestre in codice, formato da 1.679 bit ideati dallo stesso Drake docente alla Cornell University, all’“indirizzo” della Costellazione di Ercole (M13 in gergo scientifico) scoperta nel 1715 dall’astronomo inglese Edmond Halley. Se la “letterina” qui riportata in foto, venisse captata da radiotelescopi alieni, racconterebbe chi siamo.
Contiene infatti i numeri da 1 a 10, i numeri atomici di idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno e fosforo, le basi del DNA con disegno dello stesso, il disegno di un uomo, la popolazione terrestre (4,2 miliardi nel ’74), una rappresentazione del sistema solare, la figura del radiotelescopio emittente e le dimensioni della sua antenna. Tali immagini risultano evidenti facendo un grande sforzo di lettura tra le 73 righe composte da 23 numeri ciascuna (0 e 1) collocati in modo tale da disegnare i dati e le immagini voluti. Una prima occhiata ai numeri permette di scorgere solo la doppia elica del DNA e l’antenna del radiotelescopio. Ma perché qualcuno possa ricevere questo messaggio partito 34 anni fa ci vorrà del tempo: Ercole (a forma trapezoidale visibile a occhio nudo) e le sue centinaia di migliaia di stelle, dista 25.000 anni luce da noi! In ogni caso il radiotelescopio di Arecibo, che ha consentito importanti scoperte scientifiche (il reale periodo di rotazione di Mercurio, le stelle di neutroni, la prima pulsar e la prima millisecondpulsar che ruota su se stessa 642 volte al secondo, la prima immagine di un asteroide, i primi pianeti extrasolari), verrà chiuso nel 2011 se non si troveranno i fondi necessari a mantenerlo in vita. Quindi nessuno ascolterà l’eventuale risposta alla letterina dei terrestri: almeno non da lì.
Foto del primo pianeta extrasolare
Caldo, gassoso e con un anno di 318.280 giorni
Fomalhaut b. Un nome orrendo per la scoperta astronomica che apre il millennio. E’ il primo pianeta fotografato al di fuori del nostro sistema solare. Per arrivarci, viaggiando alla velocità della luce (circa 300.000 km al secondo) ci vogliono 25 anni; ma il telescopio Hubble della Nasa che orbita attorno alla Terra a 600 km di altezza, ci ha messo 7 anni a scovarlo quando si è orientato verso la costellazione del Pesce australe, vicino a Fomalhaut, un Sole giovane che ha soltanto 200 milioni di anni e brilla 16 volte più del nostro. Il risultato della ricerca è del prof. Paul Kalas dell’Università californiana di Berkeley. Anche se appare solo un puntino giallo che si perde di fronte alla massa della sua stella di riferimento, si tratta di un pianeta grande forse tre volte Giove; è gassoso e caldo e pare dotato di anelli come Saturno. Un anno su Fomalhaut b. è lungo da passare: dura infatti 872 dei nostri. E’ il primo pianeta extra sistema solare in assoluto ad essere stato fotografato, mentre di altri 300 gli astronomi hanno solo la percezione dell’esistenza per via di anomalie registrate da parte delle rispettive stelle madri. A questo punto gli scienziati ipotizzano che, più distanziato dal Sole Fomalhaut, vi possa essere anche un pianeta ospitale come la Terra. Per scoprirlo bisognerà attendere l’invio di James Webb Space Telescope, il “figlio” di Hubble che sarà lanciato in orbita nel 2013, 23 anni dopo il suo grande papà. (foto NASA)
Sindone, un’energia interiore ha “fotografato” il corpo risorto?
Ci sarebbe voluta una scarica elettrica di 50 milioni di Volt per “fotografare” sul tessuto di lino il sangue e l’impronta di Cristo sulla Sacra Sindone, così come di fatto appare: di Cristo o in ogni caso di un uomo flagellato e crocifisso che portava in testa i segni di una corona di spine, sangue attorno alle orecchie, una ferita sul lato sinistro del costato, i buchi dei chiodi sulle mani e sui piedi, i polpacci che presentavano distorsioni… Fatale somiglianza con quanto i Vangeli raccontano del Nazareno.  Così come lo scienziato americano da lui sentito, ne è convinto anche Giulio Fanti, docente di Misure meccaniche e termiche al dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università di Padova, che dopo 12 anni di studi e parecchie pubblicazioni in merito, è uscito in primavera con il volume La Sindone una sfida alla scienza moderna.
Così come lo scienziato americano da lui sentito, ne è convinto anche Giulio Fanti, docente di Misure meccaniche e termiche al dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università di Padova, che dopo 12 anni di studi e parecchie pubblicazioni in merito, è uscito in primavera con il volume La Sindone una sfida alla scienza moderna.
Il professore, già fondatore del Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali “CISAS G.Colombo” e membro di gruppi internazionali per missioni spaziali, rivela i risultati delle sue ultime ricerche, senza nascondere la propria convinzione religiosa.
“Sapevamo che l’uomo della Sindone era sulla trentina, capelli neri, alto attorno al metro e 75 (due centimetri più o due meno); che le ferite ai polsi e alla mano sinistra erano infette, che dopo essere morto di infarto per la rottura del muscolo cardiaco, il colpo di grazia infertogli con una lancia nel costato ha permesso al sangue di decantare facendolo sgorgare dalla ferita prima del siero. Con immagini digitalizzate ad altissima risoluzione ho potuto contare 213 ferite da flagello sulla schiena e 159 sul davanti. Aiutandoci con un manichino abbiamo ricostruito al computer le immagini frontale e dorsale del lenzuolo palestinese di 2.000 anni fa, che per almeno 40 ore ha avvolto quel corpo inanimato, e il risultato è l’impronta di un corpo dotato di rigidità cadaverica statuaria, la testa reclinata in avanti, le gambe distese, il piede sinistro sopra il destro e la mano destra sopra la sinistra”.
 Come si sia impressa l’immagine di quest’uomo, che secondo tre esami al Carbonio 14 eseguite in Arizona, a Oxford e a Zurigo, venne fissata sul tessuto tra l’anno 1260 e il 1390, resta un mistero: “Scientificamente è tuttora inspiegabile- dice lo scienziato padovano che giudica sbagliate le datazioni effettuate nel 1988 tra le quali ci sono variazioni di 200 anni- ed è il risultato di una fonte di energia sprigionatasi per brevi istanti, irriproducibile in laboratorio. Un collega americano, a livello statistico ha calcolato che si potrebbe ripeterla con un fascio di luce da 50 milioni di Volt, ma tale potenza oggi siamo in grado di crearla solo su una minuscola superficie, non certo su due metri di tela. Un’altra particolarità è data dal fatto che la Sindone non riporta colori, ma reazioni chimiche e che l’immagine del fronte e del dorso dimostrano la stessa intensità, come se il corpo fosse stato colpito da radiazioni da ambo le parti. La Sindone poi contiene le informazioni tridimensionali sul corpo avvolto e non esistono immagini laterali. Le impronte del sangue sono superficiali, sia davanti sia dietro, al punto da non penetrare il filo del lino”.
Come si sia impressa l’immagine di quest’uomo, che secondo tre esami al Carbonio 14 eseguite in Arizona, a Oxford e a Zurigo, venne fissata sul tessuto tra l’anno 1260 e il 1390, resta un mistero: “Scientificamente è tuttora inspiegabile- dice lo scienziato padovano che giudica sbagliate le datazioni effettuate nel 1988 tra le quali ci sono variazioni di 200 anni- ed è il risultato di una fonte di energia sprigionatasi per brevi istanti, irriproducibile in laboratorio. Un collega americano, a livello statistico ha calcolato che si potrebbe ripeterla con un fascio di luce da 50 milioni di Volt, ma tale potenza oggi siamo in grado di crearla solo su una minuscola superficie, non certo su due metri di tela. Un’altra particolarità è data dal fatto che la Sindone non riporta colori, ma reazioni chimiche e che l’immagine del fronte e del dorso dimostrano la stessa intensità, come se il corpo fosse stato colpito da radiazioni da ambo le parti. La Sindone poi contiene le informazioni tridimensionali sul corpo avvolto e non esistono immagini laterali. Le impronte del sangue sono superficiali, sia davanti sia dietro, al punto da non penetrare il filo del lino”.
Prima si sono impresse le tracce di sangue, poi quelle del corpo, mentre sono assenti impronte di sbavature di sangue e di rottura di croste: il che è abbastanza insolito pensando ad un cadavere tanto seviziato.
 “L’immagine corporea si formò per l’esplosione di una forte energia, che forse provocò il movimento del lenzuolo. La radiazione è stata direzionale e perpendicolare al corpo e non è avvenuta per contatto. Appaiono più scure solo le fibrille di lino a contatto col corpo per uno spessore di appena 200 nanometri, come se l’energia fosse venuta dall’interno di quell’uomo”. Il professore fa capire che, essendo l’immagine del corpo simile a un negativo fotografico, questa “luce” ha scurito di più le parti del lino a contatto con la pelle e meno quelle più esterne e ciò dimostra anche che non si tratta di un falso, dal momento che risultano colorate solo le parti esterne del medesimo tessuto e non le più profonde.
“L’immagine corporea si formò per l’esplosione di una forte energia, che forse provocò il movimento del lenzuolo. La radiazione è stata direzionale e perpendicolare al corpo e non è avvenuta per contatto. Appaiono più scure solo le fibrille di lino a contatto col corpo per uno spessore di appena 200 nanometri, come se l’energia fosse venuta dall’interno di quell’uomo”. Il professore fa capire che, essendo l’immagine del corpo simile a un negativo fotografico, questa “luce” ha scurito di più le parti del lino a contatto con la pelle e meno quelle più esterne e ciò dimostra anche che non si tratta di un falso, dal momento che risultano colorate solo le parti esterne del medesimo tessuto e non le più profonde.
“Abbiamo provato a riprodurre vari tipi di radiazione e la più plausibile è quella elettromagnetica. Credo sia stato il risultato dell’effetto corona, ossia simile alla scarica elettrica parziale associata a due elettrodi di carica opposta, che genera riscaldamento (forse di 10 gradi), luminescenza, ozono e un effetto acustico”.
Il telo fatto a mano
 La Sindone (il lenzuolo di lino a spina di pesce lungo 437 cm per 111) è conosciuto In Europa dal 1200, quando i Templari la prelevarono da Costantinopoli, dove Luigi VII re di Francia ebbe modo di venerarla nel 1147 nella cappella di Santa Maria del faro, a palazzo imperiale, prima di re Almarico Idi Gerusalemme nel 1171. Prima di allora in Turchia a Urfa (attuale Edessa) fin dal nel 944 si parlava del Mandyliono di Sindon, un telo “non fatto a mano” e ripiegato su se stesso, che riproduceva il viso di Gesù crocifisso: telo che fu scambiato dall’emiro al generale bizantino Giovanni Curcas con 200 prigionieri musulmani, ponendo così fine all’assedio della città.
La Sindone (il lenzuolo di lino a spina di pesce lungo 437 cm per 111) è conosciuto In Europa dal 1200, quando i Templari la prelevarono da Costantinopoli, dove Luigi VII re di Francia ebbe modo di venerarla nel 1147 nella cappella di Santa Maria del faro, a palazzo imperiale, prima di re Almarico Idi Gerusalemme nel 1171. Prima di allora in Turchia a Urfa (attuale Edessa) fin dal nel 944 si parlava del Mandyliono di Sindon, un telo “non fatto a mano” e ripiegato su se stesso, che riproduceva il viso di Gesù crocifisso: telo che fu scambiato dall’emiro al generale bizantino Giovanni Curcas con 200 prigionieri musulmani, ponendo così fine all’assedio della città.
Una reliquia così importante era sempre scortata
 In origine i quattro evangelisti già avevano parlato di un lenzuolo che avvolse il corpo di Cristo; presumibilmente la comunità cristiana che possedeva la reliquia, la portò con sé nella cittadina Pella oltre il Giordano quando nel 66 fuggì da Gerusalemme prima dell’assedio romano. Poi nel 340 S.Cirillo vescovo di Gerusalemme, nominò questo telo, nel 646 il vescovo spagnolo di Saragoza parlò del sudario, nel 650 il vescovo Arculfo pellegrino in Terrasanta, descrisse la Sindone come lunga 8 piedi (circa 230 cm) e come sudario che avvolse il capo di Gesù prima di essere tramandato di padre in figlio dalla famiglia del giudeo che lo aveva preso dal sepolcro.
In origine i quattro evangelisti già avevano parlato di un lenzuolo che avvolse il corpo di Cristo; presumibilmente la comunità cristiana che possedeva la reliquia, la portò con sé nella cittadina Pella oltre il Giordano quando nel 66 fuggì da Gerusalemme prima dell’assedio romano. Poi nel 340 S.Cirillo vescovo di Gerusalemme, nominò questo telo, nel 646 il vescovo spagnolo di Saragoza parlò del sudario, nel 650 il vescovo Arculfo pellegrino in Terrasanta, descrisse la Sindone come lunga 8 piedi (circa 230 cm) e come sudario che avvolse il capo di Gesù prima di essere tramandato di padre in figlio dalla famiglia del giudeo che lo aveva preso dal sepolcro.  PapaStefano III(752- 757) parlò di un lenzuolo su cui era stata divinamente trasferita la figura del volto e dell’intero corpo di Gesù.
PapaStefano III(752- 757) parlò di un lenzuolo su cui era stata divinamente trasferita la figura del volto e dell’intero corpo di Gesù.
La prima descrizione del sudario, Costantinopoli, anno 944
 Il 16 agosto 944 dal pulpito di Santa Sofia a Costantinopoli Gregorio arcidiacono e referendario della chiesa locale, così descrisse il lenzuolo in suo possesso, come risulta dal manoscritto conservato nella Biblioteca Vaticana: Impronta impressa unicamente dai sudori d’agonia del volto del Principe della Vita, colati come rivoli di sangue, e dal dito di Dio. Sono stati essi gli ornamenti che hanno colorato la vera impronta del Cristo. E le impronte, dopo che essi sono colati, è stata impreziosita dalle gocce del suo costato. Le due cose sono colme di insegnamenti: qua sangue e acqua, là sudore e immagine. Quale equilibrio delle realtà, poiché esse… da un unico… Ma vi si vede anche la fonte d’acqua viva ed essa disseta insegnando che i sudori artefici dell’immagine, la quale fa scorrere il fianco della natura… a ciascuno, l’hanno prodotta… A poco a poco, ci si abitua a qualcosa che non si era mai veduto prima e di cui occhio e mente non avevano esperienza.
Il 16 agosto 944 dal pulpito di Santa Sofia a Costantinopoli Gregorio arcidiacono e referendario della chiesa locale, così descrisse il lenzuolo in suo possesso, come risulta dal manoscritto conservato nella Biblioteca Vaticana: Impronta impressa unicamente dai sudori d’agonia del volto del Principe della Vita, colati come rivoli di sangue, e dal dito di Dio. Sono stati essi gli ornamenti che hanno colorato la vera impronta del Cristo. E le impronte, dopo che essi sono colati, è stata impreziosita dalle gocce del suo costato. Le due cose sono colme di insegnamenti: qua sangue e acqua, là sudore e immagine. Quale equilibrio delle realtà, poiché esse… da un unico… Ma vi si vede anche la fonte d’acqua viva ed essa disseta insegnando che i sudori artefici dell’immagine, la quale fa scorrere il fianco della natura… a ciascuno, l’hanno prodotta… A poco a poco, ci si abitua a qualcosa che non si era mai veduto prima e di cui occhio e mente non avevano esperienza.
Un’immagine non delineata sui bordi, che sfuma in niente, che se ti avvicini via via impallidisce e scompare e se ti allontani riemerge; un colore estenuato, pallidissimo, che non sapresti definire, che quasi sconfina dalla scala cromatica; due lunghe impronte di un corpo spogliato, di fronte e di schiena, così stranamente e illogicamente accostate; una quantità di segni evidentemente sanguinolenti, stampati anch’essi sulla pelle di una suprema immobilità cadaverica. … prima di sprofondare in quella lunga contemplazione senza parole che è sempre, per chiunque, la prima osservazione della Sindone. Per tutti, il primo impatto con la Sindone è un lungo guardare in un lungo silenzio.
 E si sa da La conquête de Costintantinople scritta da Robert de Clary(cronista della quarta crociata) che prima di cadere in mano europea, la città turca ogni venerdì esponeva nella chiesa di Santa Maria di Blachernae un telo che mostrava molto bene l’immagine di Cristo crocifisso. Scriveva de Clary parlando del saccheggio di Costantinopoli del 13 aprile 1204: C’era un altro dei monasteri che si chiamava Mia Signora Santa Maria di Blakerne, dove la Sindone, dove Nostro Signore fu avvolto, si trovava, che ciascun venerdì si drizzava tutta dritta, così che vi si poteva ben vedere la figura di Nostro Signore. E nessuno sa, né greco né francese, che cosa a questa Sindone accadde quando la città fu presa.
E si sa da La conquête de Costintantinople scritta da Robert de Clary(cronista della quarta crociata) che prima di cadere in mano europea, la città turca ogni venerdì esponeva nella chiesa di Santa Maria di Blachernae un telo che mostrava molto bene l’immagine di Cristo crocifisso. Scriveva de Clary parlando del saccheggio di Costantinopoli del 13 aprile 1204: C’era un altro dei monasteri che si chiamava Mia Signora Santa Maria di Blakerne, dove la Sindone, dove Nostro Signore fu avvolto, si trovava, che ciascun venerdì si drizzava tutta dritta, così che vi si poteva ben vedere la figura di Nostro Signore. E nessuno sa, né greco né francese, che cosa a questa Sindone accadde quando la città fu presa.
La Sindone lascia il Medio Oriente per l’Europa
Teodoro Angelo Comneno futuro imperatore bizantino scrisse nel 1205 al papa protestando per i massacri e le spoliazioni effettuati dai Crociati a Costantinopoli e disse tra l’altro che la Sindone era stata portata ad Atene: Sappiamo che questi oggetti sacri sono conservati a Venezia, in Francia e negli altri paesi dei saccheggiatori e che il santo Lenzuolo si trova ad Atene. A portarlo in Grecia fu forse Othon de la Roche duca latino di Atene, il quale inviò la Sindone a suo padre Pons, che a sua volta ne donò una copia (solo frontale) all’arcivescovo di Besançon Amadeus de Tramelay.
Nel Trecento il dottore della Chiesa Niceforo Callisto scrisse nella sua Storia della Chiesa che la statura di Gesù, misurata probabilmente sulla Sindone, era di 183 cm: identica misura presa successivamente dai Savoia.
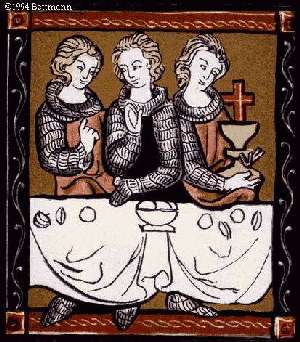 Nel 1314 vennero bruciati sul rogo come eretici i Templari francesi che adoravano un volto di Cristo riprodotto su un telo. Per salvare la Sindone (la copia?) dall’incendio della cattedrale di Besançon, il 6 marzo 1349 la reliquia venne portata in salvo e nel 1353 Geoffroy de Charny, templare che l’aveva in casa da almeno 13 anni in quanto sua moglie Jeanne de Vergy (sposata nel 1340) era pronipote di Othon de la Roche, la consegnò ai canonici di Lirey (villaggio a 100 km a sud est di Parigi) prima di morire, come alfiere reale, nel 1356 in battaglia vicino a Poitiers facendo scudo col suo corpo al re Giovanni il Buono.
Nel 1314 vennero bruciati sul rogo come eretici i Templari francesi che adoravano un volto di Cristo riprodotto su un telo. Per salvare la Sindone (la copia?) dall’incendio della cattedrale di Besançon, il 6 marzo 1349 la reliquia venne portata in salvo e nel 1353 Geoffroy de Charny, templare che l’aveva in casa da almeno 13 anni in quanto sua moglie Jeanne de Vergy (sposata nel 1340) era pronipote di Othon de la Roche, la consegnò ai canonici di Lirey (villaggio a 100 km a sud est di Parigi) prima di morire, come alfiere reale, nel 1356 in battaglia vicino a Poitiers facendo scudo col suo corpo al re Giovanni il Buono.
Il vescovo invidioso e la Sindone “raccomandata”
Dopo anni di venerazioni (a partire dal 1354 il papa concesse indulgenze ai pellegrini che si recavano a Lirey), nel 1389 Pierre d’Arcis vescovo del capoluogo Troyes, per invidia rispetto alla popolarità e alla ricchezza che stava confluendo sul villaggio a scapito della sua città, protestò con l’antipapa di Avignone Clemente VII (nipote acquisito di Jeanne de Vergy) il quale ordinò che durante le ostensioni si dicesse che quella non era l’immagine reale di Gesù. Ma al vescovo non bastava e così ordinò la sospensione delle ostensioni. Comunque era tardi, perché la chiesa era ormai meta di pellegrinaggi da tutta Europa. In una bolla del 6 gennaio 1390 quel papa disse che la Sindone era l’immagine di Cristo.
La Sindone ceduta “in nero” ai Savoia
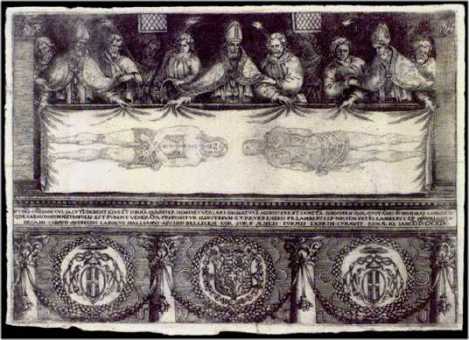 Nel 1418 per metterlo in salvo da una guerra, i canonici di Lirey consegnarono il lenzuolo al conte Umberto de la Roche che nel 1448 la lasciò in eredità a sua moglie Margherita de Charny, ultima discendente di Geoffroy de Charny, la quale nel 1453 a Ginevra, lo cedette ad Anna di Lusignano, moglie del duca Ludovico di Savoiapresso cui si era rifugiata durante la guerra dei cent’anni: si trattò solo ufficialmente di un dono, in quanto il papa non tollerava la vendita delle reliquie e quindi non poteva restare traccia di un passaggio di denaro o beni. Di fatto si sa che i Savoia saldarono i debiti della nobildonna.
Nel 1418 per metterlo in salvo da una guerra, i canonici di Lirey consegnarono il lenzuolo al conte Umberto de la Roche che nel 1448 la lasciò in eredità a sua moglie Margherita de Charny, ultima discendente di Geoffroy de Charny, la quale nel 1453 a Ginevra, lo cedette ad Anna di Lusignano, moglie del duca Ludovico di Savoiapresso cui si era rifugiata durante la guerra dei cent’anni: si trattò solo ufficialmente di un dono, in quanto il papa non tollerava la vendita delle reliquie e quindi non poteva restare traccia di un passaggio di denaro o beni. Di fatto si sa che i Savoia saldarono i debiti della nobildonna.  Da allora la Sindone rimase custodita per 59 anni nella cappella ducale del castello che i Savoia avevano nella loro capitale Chambéry, prima che l’11 giugno 1502 il duca di Savoia Filiberto II il Bello, la trasferisse nella cattedrale in quella che papa Giulio II fece poi chiamare la Sainte-Chapelle: luogo in cui la Sindone venne seriamente danneggiata dall’incendio notturno del 3 dicembre 1532. Per proteggerla da scontri armati, nel 1535 fu trasferita a Torino, Vercelli, Milano, Nizza e Vercelli dove rimase fino al 1561 prima di far rientro a Chambéry.
Da allora la Sindone rimase custodita per 59 anni nella cappella ducale del castello che i Savoia avevano nella loro capitale Chambéry, prima che l’11 giugno 1502 il duca di Savoia Filiberto II il Bello, la trasferisse nella cattedrale in quella che papa Giulio II fece poi chiamare la Sainte-Chapelle: luogo in cui la Sindone venne seriamente danneggiata dall’incendio notturno del 3 dicembre 1532. Per proteggerla da scontri armati, nel 1535 fu trasferita a Torino, Vercelli, Milano, Nizza e Vercelli dove rimase fino al 1561 prima di far rientro a Chambéry.
In Italia grazie a Testa di ferro
 Ma nel 1578, per far risparmiare 200 km al cardinale di Milano Carlo Borromeo che voleva recarsi a piedi fino in Savoia per venerare la Sindone come ringraziamento a Dio per la fine della peste, il 14 settembre il duca Emanuele Filiberto di Savoia (detto Testa di ferro)
Ma nel 1578, per far risparmiare 200 km al cardinale di Milano Carlo Borromeo che voleva recarsi a piedi fino in Savoia per venerare la Sindone come ringraziamento a Dio per la fine della peste, il 14 settembre il duca Emanuele Filiberto di Savoia (detto Testa di ferro)  la trasferì segretamente nel proprio castello a Torino, da 16 anni capitale del ducato savoiardo. Il cardinale con i suoi 13 accompagnatori, era giunto il 10 ottobre 1578 a piedi da Milano dopo quattro giorni di cammino sotto una pioggia battente e chiese subito di poter vedere la reliquia ospitata nella cappella ducale di San Lorenzo. Il giorno seguente il duca mostrò ufficialmente la Sindone alla capitale sabauda e nuovamente al futuro san Carlo Borromeo, facendola salutare con alcune salve di cannone e portandola su un palco in piazza Castello.
la trasferì segretamente nel proprio castello a Torino, da 16 anni capitale del ducato savoiardo. Il cardinale con i suoi 13 accompagnatori, era giunto il 10 ottobre 1578 a piedi da Milano dopo quattro giorni di cammino sotto una pioggia battente e chiese subito di poter vedere la reliquia ospitata nella cappella ducale di San Lorenzo. Il giorno seguente il duca mostrò ufficialmente la Sindone alla capitale sabauda e nuovamente al futuro san Carlo Borromeo, facendola salutare con alcune salve di cannone e portandola su un palco in piazza Castello.
Dall’1 giugno 1694 la Sindone si trova nella cappella appositamente realizzata nel duomo di Torino dal frate-architetto di corte Guarino Guarini. Nel giugno 1706 il lenzuolo fu nascosto a Genova a seguito dell’assedio franco-spagnolo di Torino e vi fece ritorno dopo quattro mesi.
Visite private per gli invitati alle nozze reali
In quanto reliquia privata fino al 1983, quando per volontà testamentaria di Umberto II fu regalata al Vaticano, la Sindone per secoli venne mostrata ai parenti e agli ospiti della casa reale ogni volta che qualcuno di famiglia si sposava; ma anche in occasione della nascita dei principini e persino per sancire degnamente la stipula di un contratto nuziale regale. Nel 1798 re Carlo Emanuele IV fece aprire la Sindone per trovare la forza di sopportare la fine degli Stati sabaudi: prima di fuggire in Sardegna il re e la sua famiglia vollero salutare la Sindone. Nel 1815 papa Pio VII tornato libero dopo 11 anni di prigionia a Fointainbleau, volle venerare la Sindone mostrandola alla folla torinese e pretendendo che gliene preparassero una copia su lino.
Le prime foto
 Nel 1842 durante le nozze di Vittorio Emanuele II si pensò di fotografare la Sindone, ma questo primo esperimento di dagherrotipia non riuscì. Ma è solo nel 1898 che venne eseguita la prima foto del lenzuolo, fotografo l’avvocato Secondo Pia. Assieme a lui scattarono foto il salesiano polacco Natale Noguier, il gesuita Gianmaria Sanna Solaro, l’ingegner Splendorelli e il tenente della Guardia del duomo, Felice Fino.
Nel 1842 durante le nozze di Vittorio Emanuele II si pensò di fotografare la Sindone, ma questo primo esperimento di dagherrotipia non riuscì. Ma è solo nel 1898 che venne eseguita la prima foto del lenzuolo, fotografo l’avvocato Secondo Pia. Assieme a lui scattarono foto il salesiano polacco Natale Noguier, il gesuita Gianmaria Sanna Solaro, l’ingegner Splendorelli e il tenente della Guardia del duomo, Felice Fino.
Durante la seconda guerra mondiale, tra il 1939 e il 1946, anziché a Cassino come si pensò di fare in un primo momento, il lenzuolo venne segretamente portato in provincia di Avellino nel santuario di Montevergine.
Nel 1969 prime foto a colori della Sindone e nel 1973 prima ostensione televisiva. Verrà nuovamente esposta ai fedeli nella primavera del 2010 nel duomo di Torino.

Castrazione temporanea per cani e gatti
(per Focus n. 172, febbraio 2007)
Finalmente contraccezione maschile. Per cani. Niente cuccioli e, se necessario, blocco dell’aggressività. Tutto con una puntura ogni sei mesi. Il Deslorelin, il principio attivo, blocca infatti lo stimolo alla secrezione di testosterone, senza effetti collaterali: gli animali si accoppiano, ma non si riproducono.
Reversibile. “In pratica- spiega Stefano Romagnoli, responsabile del Servizio di riproduzione veterinaria dell’Università di Padova– castra in modo farmacologico (quindi reversibile) l’animale e ne riduce l’aggressività”. Il farmaco è contenuto in un cilindretto oleoso da iniettare nella collottola, che sciogliendosi rilascia la sostanza.
Criniera. L’animale si accoppia, ma per 6 mesi non è fertile. “sperimentato su 15 cani e 7 gatti, ha evitato la castrazione chirurgica” dice Romagnoli. Allo Zoo safari di Fasano (Brindisi) lo somministrano a orsi e leoni che si riproducono troppo: l’iniezione preserva il rango sociale dei leoni nel branco e salva la criniera, che con la castrazione chirurgica cadrebbe.

Il robot si fa umano
L’effetto è quello di un film di fantascienza, invece è tutto incredibilmente vero. Hanno fatto rivivere Albert Einstein. Gli hanno ridato la faccia, ma soprattutto la mimica. Ma non si tratta di una statua di cera, bensì di un robot rivestito con la pelle sintetica del duemila: la Frubber.
Il robot Albert Hubo, alto un metro e 20, cammina, ondeggia, muove le mani, strizza l’occhio, corruga la fronte, guarda negli occhi chi gli parla, esprime stati d’animo, interagendo con l’ambiente circostante. A differenza dei precedenti robot a questo è stato dato un qualcosa in più che lo umanizza: la faccia. E una faccia decisamente espressiva, come se disponesse anch’essa delle migliaia di muscoli che hanno gli umani.
Albert può correre e camminare per ore con l’energia fornita da comunissime pile alcaline e consuma pochissimo, appena un ventesimo di quella dei precedenti sistemi. Tanto l’androide quanto il sistema di movimento sono in fase di sviluppo, specie per quanto riguarda gli aspetti dell’intelligenza artificiale.
E’ l’ultima frontiera del robot dopo Asimo di Honda, il Sony Sdr-4x, ora ribattezzato Qrio e Pino, il robot tecnologico della ZMP. La tecnologia sviluppata da Hubo Lab (Humanoid Robot Research Center) del Kaist (istituto per la scienza e tecnologia finanziato dal governo sud coreano),è top secret. Al momento, a parte la faccia, il resto del corpo è quello molto robotico di Asimo. E dopo l’androide Eva (1,60 di altezza, aspetto di ragazza) e Einstein, il Centro di ricerca coreano si sta ora dedicando a un robot dalle fattezze del creatore della fantascienza moderna Philip K. Dick. Il merito della fisiognomica di questo progetto è di David Hanson, giovane promessa dell’Institute for Interactive Arts and Engineering dell’Università del Texas. (foto www.hansonrobotics.com).

Scoperta padovana per ridurre la cecità nei bambini
(Corriere del Veneto 14 luglio 2006)
“Il mio cervello era già fuggito all’estero. Poi è tornato grazie a Telethon e ora rischia di andarsene di nuovo”. A dirlo è Luca Scorrano, 35 anni padovano, uno dei più promettenti ricercatori italiani, quello di cui ieri l’americana Cell, la più autorevole rivista di ricerca biomedica, ha pubblicato ben due lavori: ed è molto se si pensa che è la prima volta che accade a uno scienziato italiano e che Cell accetta mediamente solo il 2% di ciò che le viene presentato.
Il grido d’allarme è partito ieri dalla sede dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) dove Scorrano e i colleghi Christian Frezza di Spinea e Sara Cipolat di Pordenone hanno lavorato tre anni realizzando una scoperta su cui saranno sviluppate le terapie per ridurre i casi di cecità prescolare dovuti all’atrofia ottica dominante, che in Italia colpisce un neonato su circa 30.000.
Scorrano si confida: “A Boston dove per tre anni ho lavorato al Dana -Farber Cancer Institute della Harvard University, ho incontrato investitori disposti a donare alla ricerca anche 50 milioni di dollari. In Italia chi dà 20.000 euro si sente un mecenate… Lì, ma anche in Europa, la ricerca è un mercato come quello dei calciatori e i giovani scienziati vengono pagati come dei dirigenti. Se le nostre aziende avessero il coraggio di investire i ricercatori farebbero salti di gioia pur di restare”. E così dicendo ammette che le prime proposte di ingaggio da parte di istituti di ricerca europei gli sono già arrivate.
La scoperta di Scorrano ottenuta studiando OPA1, proteina indispensabile al controllo delle cellule che devono “suicidarsi” per consentire il normale funzionamento dell’organismo, è costata mezzo milione di euro ed è avvenuta negli attrezzati laboratori dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare, grazie all’impiego di apparecchiature molto sofisticate che arrivano a costare anche un milione ciascuna. Chi ha pagato? L’Istituto Telethon Dulbecco, “Un istituto virtuale, senza sede- spiega il portavoce Marco Piazza– che foraggia 25 giovani ricercatori italiani riportandoli in patria: oltre a Scorrano sono presenti a Padova Manuela Zaccolo e Marco Sandri, mentre gli altri lavorano al San Raffaele di Milano e tutti corrono il rischio di espatriare nuovamente se il mondo della ricerca e il CNR non sapranno accoglierli”.
Gli fa eco il prof. Stefano Schiaffino vice presidente del VIMM, che parla di fallimentare tentativo di far rientrare i cervelli, dovuto ad un organismo governativo privo di basi scientifiche. E il prof. Francesco Pagano, presidente dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare, sottolinea la preziosità di strutture come il VIMM, il cui direttore scientifico Tullio Pozzan è stato da poco chiamato a far parte della prestigiosa Accademia Nazionale Americana delle Scienze assieme a due soli altri due italiani: Rita Levi Montalcini e il biologo Rino Rappuoli.
Il direttore del Dipartimento Scienze Biomediche sperimentali dell’Università di Padova, prof. Paolo Bernardi, ricorda che il VIMM, polo di eccellenza nello studio della genetica, è una costola dell’Università di Padova e collabora con il Dipartimento Ricerca Universitaria Biomedica. “Siamo imbrigliati in un nodo legislativo- prosegue il docente- perché il Dipartimento non ha strumenti per reclutare i giovani brillanti laureati. Cosa che strutture più snelle come il VIMM possono fare. Se ci fossero i fondi, oltre a riportare in Italia i nostri “cervelli” riuniremmo qui anche quelli stranieri”.
Il prof. Pagano chiama a raccolta la città di Padova e quanti credono nella ricerca: “Siamo nati con i contributi del Comune, della Fondazione Cassa di Risparmio e di venti imprenditori del Nord Est. Ora vogliamo creare un centro ricerche di Proteomica, dove studiare le alterazioni genetiche; ma servono almeno quattro milioni di euro. Sarebbe bello se i padovani sentissero questo progetto anche un po’ loro”.
Roberto Brumat
Talpa italiana su Marte

(Corriere del Veneto 21 settembre 2005)
Se le talpe sapessero parlare, quella che nel 2011 andrà su Marte con la missione spaziale europea Aurora si esprimerebbe in veneto. La talpa automatizzata che verrà fatta cadere sul suolo marziano in cerca di giacimenti sotterranei d’acqua, è infatti nata all’Università di Padova dopo otto mesi di gestazione ed è figlia di scienza e industria: un team di 15 scienziati del CISAS (Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali “G.Colombo”) unito agli ingegneri della veneziana Tecnomare Spa (gruppo ENI), società di engineering per impianti petroliferi marini.
Si tratta di un robot autonomo, un cilindro tecnologico in titanio e acciai speciali, unico al mondo nel suo genere, lungo 120 centimetri e capace di scavare un foro largo dieci cm. fino a cento metri di profondità. “Abbastanza per trovare l’acqua” si augura il direttore del CISAS Francesco Angrilli, non nuovo alle imprese marziane: vedi la realizzazione dei misuratori di temperatura, pressione, densità e rumore dell’atmosfera di Titano, che hanno svolto egregiamente le loro tre ore di lavoro il 14 gennaio scorso, facendo sapere all’umanità che il satellite di Saturno ha una temperatura al suolo di meno 200 gradi (meno 90 a 100 km di altezza), una pressione una volta e mezza quella terrestre, 12 strati di inversione termica nell’alta atmosfera (sono due sulla terra) e che un oggetto in caduta libera fa rumore, come dimostra la registrazione fatta mentre la sonda Huygens, un mini disco volante, scendeva a 1.500 km orari, frenata dai paracadute dopo che lo scudo termico aveva resistito a 11.600 gradi: due volte la temperatura della superficie solare.
Fantascienza, come dalla fantascienza esce la talpa veneta che l’Ente Spaziale Europeo ESA verrà a provare lunedì 26 settembre al CISAS, dopo averla dichiarata vincitrice del bando europeo, primo di oltre 100 concorrenti di tutto il continente e del Canada, con 250.000 euro di premio.
“Ne abbiamo spesi 100.000 in più per realizzarla- spiega lo scienziato- e costerà 10-15 volte tanto riprodurla in edizione spaziale, con i materiali più idonei a resistere alle sollecitazioni di Marte. Il nostro prototipo usa infatti un’elettronica terrestre che andrà cambiata”.
Che sa fare questo animale spaziale? Scava, avanza come un verme dilatandosi e restringendosi grazie a un motore miniaturizzato che cambia continuamente l’aderenza al foro, curva inclinandosi fino a dieci gradi e si àncora al suolo. Con cinque lame rotanti e un movimento percussivo taglia le pietre che incontra e, attraverso un tubo centrale le trasporta nella parte finale dove in poco più di un decimetro cubo di spazio un microscopio spettrografico analizza i frammenti comunicando i dati alla stazione esterna a cui la talpa è collegata con un cordone ombelicale che la rifornisce anche di energia: appena una decina di watt.
“Come dimostrerà la prova finale di lunedì fatta con cilindri riempiti dei possibili minerali marziani, questo robot è in grado di sminuzzare in dimensioni submillimetriche rocce dure come basalti e graniti: in questo caso l’avanzamento è di pochi millimetri all’ora, mentre in presenza di pietre meno coriacee procede anche a 10 centimetri l’ora”. I risultati dei primi esperimenti sono stati buoni sulla pietra di Vicenza e sul marmo rosso di Trento.
A livello progettuale il team di ricerca CISAS -Università di Padova che ha realizzato l’acceleratore iperveloce unico al mondo per lo studio di ipotetici impatti con gli asteroidi, sta lavorando su un avveniristico motore spaziale, capace di velocità inimmaginabili. “Su un motore da 2 megaWatt gli americani hannoinvestito molto- conclude il prof. Angrilli- I nostri fondi invece sono pochi, quindi da due anni assieme ad alcuni ricercatori del Progetto RFX e a un gruppo del Politecnico di Torino, studiamo un sistema da 20 kWatt che potrebbe essere utilizzato per manovre in missioni orbitali, ed anche per trasportare piccoli carichi in viaggi interplanetari. Alcuni nostri dottorandi hanno lavorato al progetto di un grande motore a plasma sviluppato sotto il controllo del centro NASA di Houston, per missioni umane verso il pianeta rosso. Motore che rappresenta la nuova frontiera dei viaggi spaziali: dopo la spinta convenzionale del razzo, entra in funzione il motore a ioni molto densi che fornisce al vettore un’accelerazione blanda, ma costante, fino alla frenata in fase di avvicinamento. Se oggi raggiungere Marte (6 mesi di andata, attesa della congiunzione tra i pianeti, più ritorno) significa perdere tre anni, col nuovo motore per andare sul pianeta rossoe soggiornarvi due settimane, basterebbero tre mesi.
Roberto Brumat
A Castelfranco la 1^ laurea breve in Economia

I turisti vengono nel Veneto più per le Dolomiti o per farsi incantare da Venezia e dalle bellezze artistiche delle nostre città? Ma quale ambiente e arte! Ci vengono per mangiare e bere bene, lo dice uno studio della Regione. Per questo (ma non solo) l’Università di Padova, unica in Italia, ha indetto un corso di laurea breve in Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione, che apre il 26 settembre a Castelfranco.
In tre anni cinquanta studenti (47 italiani e tre extracomunitari tra cui una palestinese) non imparano, beninteso, a cucinare, ma a gestire produzioni, controlli qualitativi e commercializzazione dei cibi oltre che a progettare e gestire anche a livello economicoristoranti, mense, catering.
“La cucina Made in Italy non possiamo lasciarla all’improvvisazione” dice il rettore Vincenzo Milanesi firmando la convenzione con l’Accademia italiana della cucina, istituzione culturale della Repubblica sorta nel ’53. All’Accademia e a realtà del mondo produttivo, il compito di fornire personale docente per consentire ai futuri laureati di iscriversi all’ordine dei Dottori agronomi e forestali come “Agronomi junior”. E’ infatti la facoltà di Agraria, assieme a quelle di Economia e Lettere e Filosofia, la promotrice dell’iniziativa. “Collaboriamo già con tre Atenei, ma a Castelfranco parliamo per la prima volta di ristorazione in un corso di laurea” precisa il presidente dell’Accademia
Giuseppe dell’Osso. E’ il segno dei tempi, come dimostrano gli studi di Agraria, che dal campo si spostano sempre più verso la tavola. Il preside Giovanni Bittante spiega che il nuovo corso insegnerà storia degli alimenti e rapporto cibo- società, preparando alle responsabilità professionali. Al primo anno si studiano matematica, informatica e biologia applicata, chimica, inglese, economia, tecnologie della gastronomia, valutazione sensoriale.
Che c’entra l’Università con la buona cucina? A guardar bene c’entra. Studenti e professori bolognesi fondatori dell’Ateneo patavino non alloggiarono forse in una locanda detta Bò, e il presalario con cui la Serenissima aiutava gli studenti poveri non consisteva forse in mastelli di vino e staie di grano? E Galileo professore a Padova, oltre a scoprire le macchie solari, non cucinava forse per gli allievi che teneva a pensione in Contrà dei Vignali, alzando spesso il gomito lui stesso?
Roberto Brumat
Il metallo che rimbalza si produce in Italia

(Focus n.157, novembre 2005)
Una biglia di metallo cade dal tavolo e lascia un solco sul parquet. Sbagliato, rimbalza come una molla. Sempre che sia di metallo amorfo, cioè composta del mix di zirconio, titanio, nikel e altri elementi, che ne fa uno dei nuovi ritrovati delle nanotecnologie: frutto di 30 anni di ricerca della Liquidmetal, società californiana che in collaborazione con dodici Università americane, nel ’93 ha brevettato queste leghe e ne detiene l’esclusiva. Col raffreddamento ultra rapido della massa fusa il composto perde la struttura cristallinadel metallo acquisendone una più simile al vetro, il che gli conferisce doti uniche: niente punti deboli, rapporto resistenza/peso due volte superiore al titanio, deformazione elastica fino al 2%, elevata durezza superficiale, resistenza alla corrosione, biocompatibilità e scarsa conducibilità termo- elettrica.
Nel ’99 per ridurre il peso del satellite Genesis lanciato verso Marte (ogni kg in orbita costa 40.000 euro) la Nasa usò un collettore di vento solare in metallo amorfo, due volte più leggero dell’equivalente in titanio.
“Può avere innumerevoli applicazioni- dice Peter Thomson Smith della Liquidmetal – dipende dalle percentuali di metalli impiegate. Inoltre, essendo iniettabile come un polimero, senza ritiro da raffreddamento e solidificazione, non richiede lavorazioni meccaniche”.
Per le qualità antigraffio e la superficie liscia, è impiegato per telefoni cellulari, sci, racchette da tennis, orologi, protesi al ginocchio, e funziona pure come cd audio. Presto, grazie a MaTech, centro ricerca materiali del Parco Scientifico di Padova, oltre che nello stabilimento in Corea verrà prodotto su licenza anche nel Veneto.
Roberto Brumat
Telemedicina, una realtà
(Corriere del Veneto 6 giugno 2003)
La telemedicina non è più fantasanità, ma una realtà concreta per il Veneto, tanto che la Regione la considera fattore strategico nel nuovo piano sanitario locale: perché fa risparmiare sulle prestazioni e permette di portare un’assistenza specialistica anche nelle zone più lontane. In una parola: dove non arriva il medico, arriva il suo computer.
Che significa lo ha spiegato ieri l’assessore regionale alla Sanità Fabio Gava in un convegno a Bionova in Fiera a Padova, parlando di servizi di cura e assistenza forniti al paziente via pc.
In regione, come ha rilevato il direttore generale dell’Ulss 9 Treviso Claudio Dario chiamato a costituire una comunità di referenti di Telemedicina in ogni struttura sanitaria, sono attive 55 applicazioni, di cui 37 di natura clinica, 9 assistenziali, 6 formative e 3 di altro genere. Sono state inoltre avviate tre comunità virtuali per consulti neorochirurgici, per cardiologia e nefrologia. Sul piano clinico le principali applicazioni di telemedicina nel Veneto riguardano la teleradiologia (nel 65% delle strutture venete), il telelaboratorio (52%) e la telecardiologia (22%). Ma è il progetto (premiato nel 2003 al Forum della Pubblica Amministrazione) il fiore all’occhiello di questa nuova Telemed Escape frontiera della sanità veneta: si sta infatti per consentire ai medici di famiglia (e anche ai pazienti) di scaricare i referti nel proprio computer.
Qualche esempio di realizzazione concreta. La facoltà di Bioingegneria dell’Università di Padova ha collaborato con l’Ateneo di Pavia e con centri ricerca tedeschi e spagnoli, al progetto europeo M2DM per diabetici, presentato ufficialmente a Bionova 2003. Si tratta di una nuova tecnologia che permette al medico di analizzare i dati speditigli in via telematica dal paziente per le necessarie modifiche del trattamento.
A Padova è stata testata per la prima volta su 70 pazienti una nuova tecnologia fiorentina per la misurazione della glicemia nei diabetici attraverso microdialisi. In sostanza il paziente indossa una scatoletta da cui esce una fibra di cellulosa rigenerata che entra nella cute; il sistema Glucoday ora applicato ambulatorialmente, evita al paziente i 5 prelievi quotidiani sottoponendolo a circa 1.000 test in 48 ore. L’apparecchio scarica con l’infrarosso i dati sul computer che via Internet li trasferisce al portatile del diabetologo. Il sensore (novità assoluta) sarà impiegato anche per diagnosi notturne, evitando al malato di entrare in coma nel sonno.
Tutta trentina la telediagnosi di patologie. L’apparecchio costruito dal fisico Francesca De Michelis del Centro Ricerca Scientifica e Tecnologica, si userà quando sarà necessario il consulto di un luminare durante un intervento chirurgico. Così ad esempio, un cardiologo dal suo computer di Padova comanderà la telecamera del microscopio robotizzato calato su un paziente in un ospedale sardo.
Roberto Brumat

Sniffatore di mine
(Focus n. 84 ottobre 1999)
Un grande aiuto nella ricerca delle mine giunge da metodi, per così dire, biologici. Come l’impiego di cani (ma all’Università di Anversa si addestrano anche topi), che grazie al fiuto riescono a percepire i vapori di esplosivo che si sprigionano dalle mine. Ma anche un naso elettronico, installato su un robot, può funzionare bene (in Italia sta lavorando in questa direzione il Laboratorio di Robotica dell’Università di Brescia).
Roberto Brumat
Lo spazzaturometro
(Focus n.69 luglio 1998)
Presto gli italiani pagheranno la tassa sui rifiuti a seconda di quanta spazzatura “differenziata” produrranno. E per misurare la quantità di rifiuti quotidiani smaltita, una società di Campogalliano (Mo), la Tata, ha lanciato lo spazzaturometro: un cassonetto che si apre se riconosce la chiave elettronica dell’utente, pesa i rifiuti introdotti e comunica al computer della nettezza urbana la quantità dei rifiuti smaltita da ogni famiglia.
Il cassonetto inoltre è in grado di avvertire via radio il centro di controllo quand’è pieno. “Con questo sistema sarà difficile imbrogliare” dice Stefano Righi della Tata “ e se una famiglia smaltisce poco, la nettezza urbana potrà accorgersene e chiedere spiegazioni”.
Roberto Brumat
In autostrada azoto antinebbia
(Focus n.64 febbraio 1998)
Con 1.600 lire di azoto liquido un km di autostrada rimane libero dalla nebbia per due ore. L’hanno sperimentato i tecnici delle Autovie Venete sul tratto dell’A4 tra Portogruaro e Venezia. Quando la nebbia riduce la visibilità a meno di 50 metri, un camper va avanti e indietro liberando azoto liquido da due bombole da 50 litri. Il sistema è stato ideato dagli scienziati dell’Attex di Mosca. I 19 esperimenti compiuti sulla Trieste- Venezia hanno dato esito positivo in dieci casi, dimostrando che l’azoto liquido è in grado di liberare la strada fino a un’altezza di 15 metri con costi molto ridotti. Lo stesso sistema funziona da novembre all’aeroporto di Parma, il primo in Italia ad adottarlo.
Roberto Brumat

forse siamo la prima civiltà avanzata sviluppata nella nostra galassia. E sempre forse, non è fisicamente possibile per un organismo vivente coprire le immense distanze tra galassie diverse. In definitiva lo sviluppo di vita è altamente probabile, ma lo sviluppo di vita intelligente è estremamente improbabile. Sulla terra i batteri si sono formati subito dopo il raffreddamento della crosta (circa 4 miliardi di anni fa), ma solo recentemente (300 milioni di anni fa ) si sono sviluppate le prime forme di vita pluricellulari. E quello è solo l’inizio del lungo processo di evoluzione del sistema nervoso e dell’intelligenza. Quindi ci sono voluti più di 4 miliardi di anni. Ovviamente in ogni momento può piombare un meteorite e cancellare ogni forma di vita. E si riparte da zero…